Sullo Spazio Umanitario
Fiamma Ficcadenti
Con il termine Spazio Umanitario ci si riferisce allo stesso tempo sia a un luogo fisico che a una dimensione teorica, è un posto strano e ce ne sono pochi come lui, per fortuna aggiungerei.
Il termine è usato in maniera diffusa ma spesso confusa e impropria. La sua prima teorizzazione ce la fornisce Rony Brauman (medico francese, presidente di Médecins sans frontières tra il 1982 e il 1994) il quale, pur non avendo coniato letteralmente tale espressione, per primo getta le basi di un suo fondamento teorico. Nel 1992 infatti, Brauman definisce “lo spazio dell’azione umanitaria” attraverso tre istanze che tale dimensione dovrebbe manifestare: è uno spazio la cui esistenza è motivata dall’essere luogo fisico e ambito di intervento dentro cui si realizza il sostegno dei soggetti in difficoltà; lo Spazio Umanitario può generarsi solo in contesti che presentano caratteri di forte e improvvisa discontinuità con una condizione di equilibrio precedente (territori colpiti da guerre o calamità naturali); gli attori che agiscono nello Spazio Umanitario devono essere indipendenti dal punto di vista politico, economico e ideologico (mah!).
Dunque, dal punto di vista teorico, l’esistenza dello Spazio Umanitario appare come un’esigenza del sistema umanitario di costruirsi un orizzonte operativo (fisico e teorico) dentro cui poter agire.
Ma dal punto di vista concreto c’è da chiedersi quale sia la spazialità dello Spazio Umanitario e che orizzonti, questa volta fisici, sia in grado di generare.
In pratica, è effettivamente un luogo? La risposta è sì e potremmo esserne pure contenti. Il problema è che tra la teoria e la pratica c’è sempre il problema che siamo di sinistra e questo passaggio ci è ostico per definizione e perché il neoliberismo ama metterci del suo, sempre.
Dunque. Lo Spazio Umanitario possiamo intenderlo come “l’espressione fisica e geografica di un concetto umanitario”(Pugh, 1999). In questo senso, si può identificare come tutte quelle porzioni di territorio sottratte alla guerra (pensate ai “corridoi umanitari”) e poste al sicuro dai disastri e dalle calamità. Come risultato di un’operazione di sottrazione, la spazialità dello “Spazio Umanitario si configura come uno spazio ‘eccezionale’, ovvero come qualcosa che eccede lo spazio normato e regolato in cui viviamo abitualmente. È uno spazio ‘confinato’ che si pone anche al di là della sovranità locale, è uno spazio universale e “assoluto” (da ab-soluto, sciolto, slegato, libero da legami), nonché ‘assolto’ dalle leggi, godendo di una sua specifica giurisdizione solitamente in capo al sistema umanitario internazionale.
In questo senso, lo Spazio Umanitario è “l’antimateria della sovranità” (Clouette, Wise, 2017), cioè un’extraterritorialità che agisce globalmente sul piano del suo costrutto teorico (il sistema umanitario si muove liberamente su tutto il pianeta) ma che determina conseguenze spaziali localmente. Dentro questo spazio si producono forme architettoniche e urbane (pensate ai campi profughi che ne sono l’estrema rappresentazione) che ‘includono escludendo’ come ci ricordano Bauman e Agamben, attraverso l’utilizzo di dispositivi spaziali come i muri, i recinti, barriere di ogni tipo che generano confini asimmetrici in grado di selezionare ciò che deve entrare e ciò che non deve uscire. Frontiere che delimitando uno spazio “d’eccezione”, consacrano la vita umana localizzata al suo interno a simbolo globalizzato di un’umanità da salvare.
Questo tipo di generalizzazione della figura dell’uomo e della donna da salvare che diventano icone di un’umanità perduta, alimenta un certo tipo di stereotipo che ha delle profonde conseguenze dal punto di vita spaziale.
Le forme dello Spazio Umanitario, infatti, sono spesso affette da una generale tendenza all’indifferenza per l’individualità dei soggetti per i quali sono prodotti; sono a-specifiche e la loro capacità espressiva è limitata a tal punto da rappresentare il grado zero della funzione. Si parla spesso di “effetto container” per quanto riguarda lo spazio umanitario: il container è effettivamente l’espressione formale e spaziale più sintetica possibile per esprimere la logica del “contenitore”, un recipiente assolutamente indifferente alla natura del contenuto che vi viene riversato dentro, ovvero, nel nostro caso, la vita umana.
In poche parole, i processi di de-individualizzazione e spersonalizzazione delle persone su cui si riversa l’azione umanitaria comportano una banalizzazione delle forme spaziali per lui costruite: l’architettura per lo spazio d’emergenza appare come una sorta di costruzione dell’ovvio, un’architettura dell’inconsistenza, oltreché – a volte e paradossalmente – un’architettura della violenza.
E qui vi metto una diapositiva (la foto non è mia) di quello che intendo. Questa e il campo profughi siriano di Azraq in Giordania, gestito dall’UNHCR. Al luglio del 2020 ospitava più di 36 mila profughi siriani, di cui il 21% bambini con un’età inferiore ai 5 anni. Con ogni probabilità sono nati nel campo.
L’ho visto con i miei occhi nel 2018. Solo da fuori perché ovviamente non sono potuta entrare.
Se questo è un luogo, umanitario.

Dunque, oltre a quanto detto fin qui, una cosa importante da aggiungere è che qualunque operazione di costruzione e configurazione dello spazio è sempre un atto di natura politica. Infatti, è nello spazio che si esercitano le relazioni sociali tra gli individui e la forma che lo spazio assume può imporre a queste relazioni precisi rapporti di forza, dominazione e subordinazione tra i soggetti. E’ un principio alquanto noto, abbastanza scontato, direi banale.
Eppure, sulla base delle premesse gettate, uno spazio per essere definito Umanitario deve essere svincolato da qualunque appartenenza politica. Ma voi, guardando la foto sopra, non vedete come vedo io forse uno degli spazi più ideologici che possa esserci? E quale ideologia soprattutto? Io ci vedo uno spazio costruito sulla base di un principio che pone come unico obiettivo la salvaguardia biologica del profugo. Deve sopravvivere come corpo. Non è uno spazio di diritto, non è uno spazio per esistere.
Inoltre, come ribadito dall’ONU, i diritti umani in generale sono interdipendenti tra loro e dalla violazione del diritto ad abitare uno spazio adeguato derivano, a cascata, una serie di violazioni di altri diritti. In particolare, viene sottolineato come l’espulsione forzata dal proprio luogo di residenza e da ciò che viene considerato “casa”, sia una delle cause originarie di violazione dei diritti umani più violente e pervasive. Da questa forzatura derivano, spesso, la perdita dei diritti politici e di voto, l’impossibilità di accedere ad un sistema sanitario ed educativo e in ultima istanza la perdita della sicurezza dell’incolumità della propria persona.
La questione dei diritti umani e del diritto a poter abitare uno spazio dignitoso meriterebbe un serio approfondimento. Quello che mi limito a sottolineare è che dal punto di vista del diritto internazionale, la questione è affrontata in termini di diritto all’accesso ad un “adequate housing”, ad un “alloggio adeguato” rispondente a determinati standard qualitativi normati dai regolamenti internazionali.
L’uso del termine “housing”, in questo contesto assimilabile con gli altri termini inglesi di “dwelling” e“shelter”, rimanda alla figura dell’alloggio inteso in senso stretto come costruzione/dimora, casa in pratica. Tuttavia, è necessario sottolineare come questo concetto, nell’orizzonte dei diritti umani, debba essere inteso in senso estensivo come “HABITAT umano” (complesso delle condizioni ambientali e naturali, delle strutture e dei servizi che caratterizzano un’area di insediamento umano consentendo la vita e le attività umane):
«Adequate housing must provide more than four walls and a roof»
Sono poi esplicitati diversi criteri che specificano più approfonditamente i valori che l’housing oggetto del diritto deve avere: sicurezza del possesso, ovvero non viene ritenuto adeguato nessun luogo i cui abitanti non abbiano titolo/diritto di occupare e debbano costantemente temere di perdere in seguito ad un’azione forzata da parte di soggetti esterni; deve consentire l’accesso a servizi, alle risorse materiali, alle strutture e alle infrastrutture necessarie allo svolgimento della vita quotidiana; deve essere accessibile e non deve sussistere nessuna barriera discriminatoria di tipo fisico, economico o politico che possa limitarne il godimento; deve essere abitabile, garantendo la sicurezza e l’incolumità fisica dei suoi residenti; deve avere una localizzazione adeguata e non predisporre alcun tipo di svantaggio per il suo porsi in aree marginali e/o pericolose; deve dimostrare un certo livello di adeguatezza culturale consentendo l’espressione dell’identità culturale dei suoi abitanti.
Mi pare chiaro come queste buone intenzioni trovino poi nella pratica, come dire, delle resistenze ad attuarsi. [politically correct, potrei dirlo molto diversamente].
La verità è che sulla scorta di influenze moderniste, funzionaliste e neoliberali lo Spazio Umanitario troppo spesso si dà come luogo “normalizzato” per eccellenza, grado zero della vita che è intesa come “nuda vita” biologica.
Uno spazio concepito come un supporto neutro su cui operare decisioni razionali e razionalizzanti dal punto di vista della pianificazione e della progettazione e dove la norma si spazializza “così come è”, dove lo standard è l’unico parametro morfogenetico della costruzione e dove non vi è spazio per la rielaborazione né degli architetti (che latitano) né delle comunità insediate.
La verità, forse, è che lo Spazio Umanitario potrebbe anche servire. Ma a me non piace per niente come lo costruiscono.

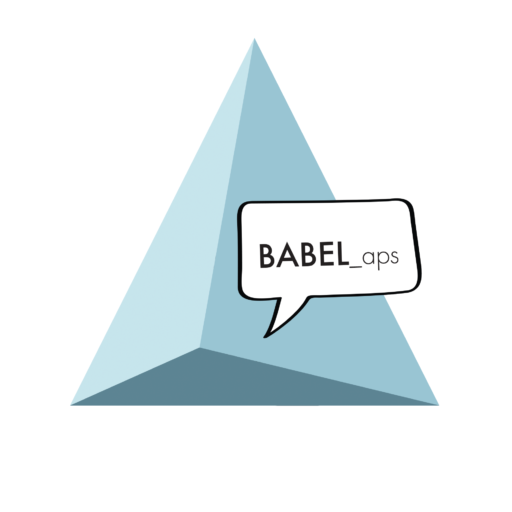
Lascia un commento